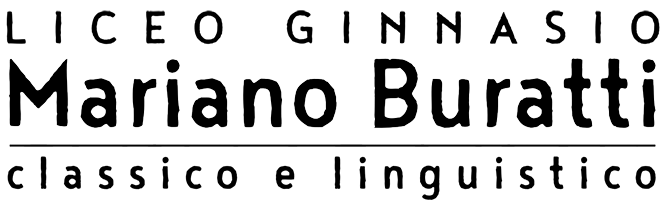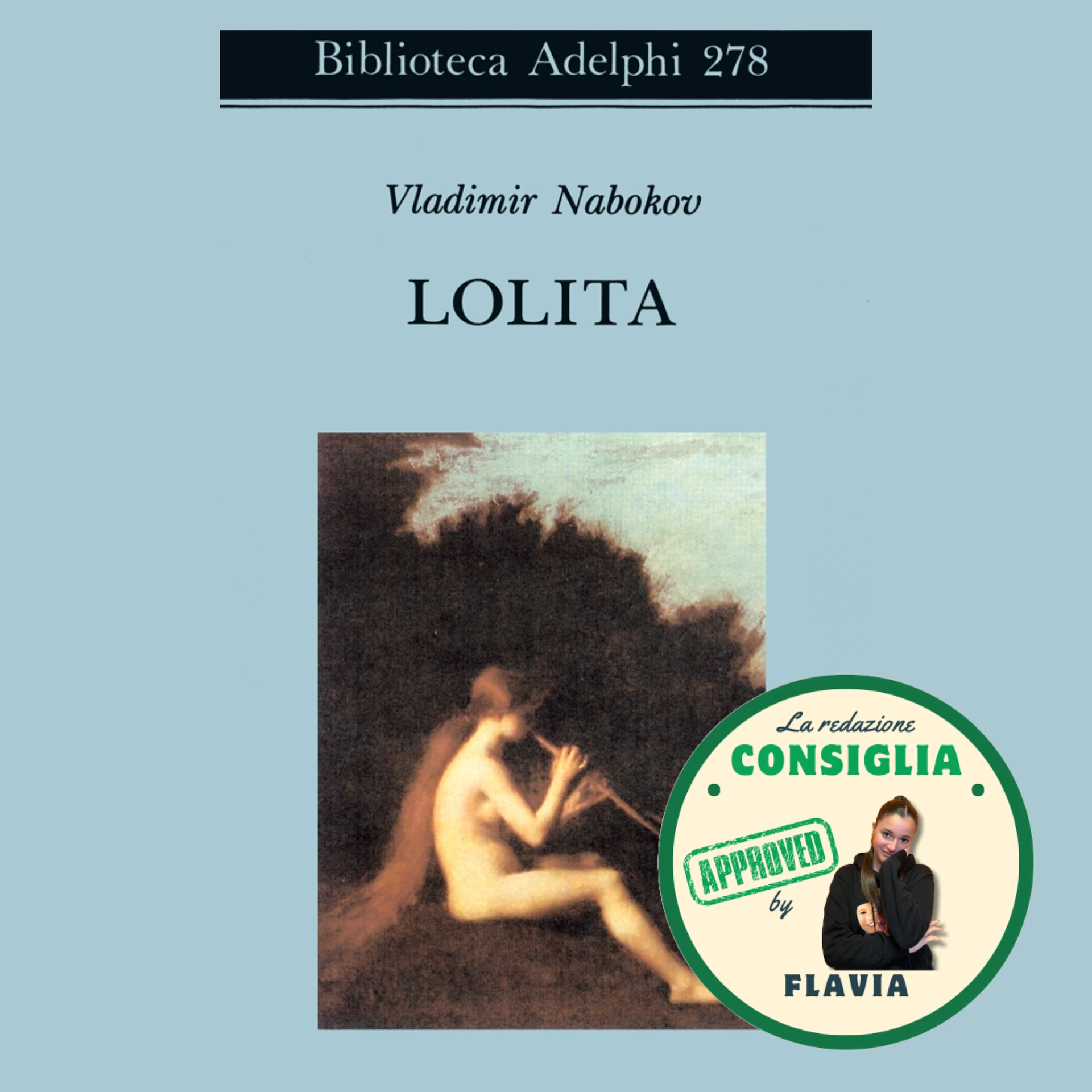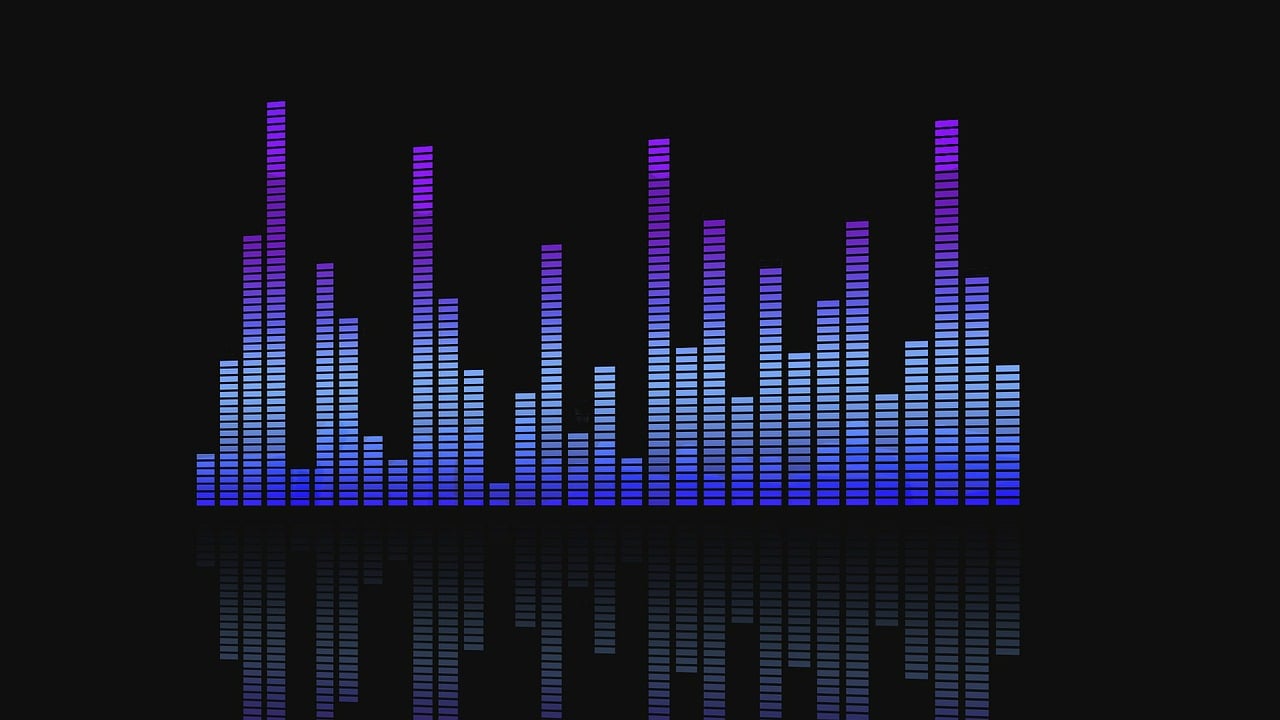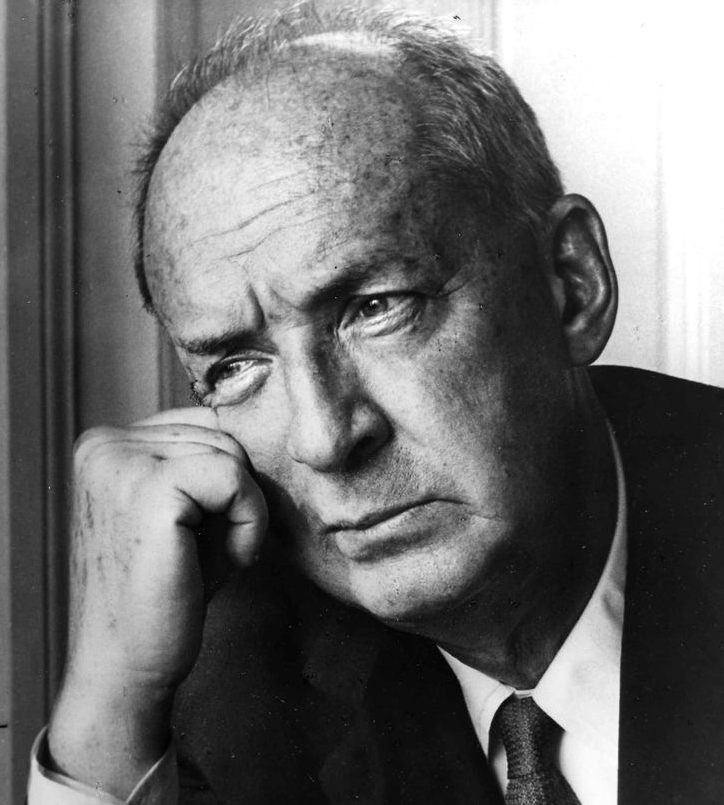
Lolita di Vladimir Nabokov è stato uno dei libri più controversi e acclamati del XX secolo. Pubblicato nel 1955, il romanzo ripercorre la passione malsana e maniacale di un uomo maturo, il professore trentasettenne Humbert, per Dolores, da lui chiamata Lolita, la figlia dodicenne di sua moglie. Morta sua moglie Humbert diventa il tutore legale di Lolita e da li, grazie a un viaggio on the road, inizia la storia di perversione e pedofilia che diventa con il passare dei capitoli sempre più contorta. La narrazione è descritta in prima persona da Humbert, il che consente a Nabokov di oscillare tra il punto di vista contorto del protagonista e l’intensa eleganza stilistica della sua prosa. La narrativa non può che essere definita magnetica, ma le sue implicazioni morali sono devastanti.
Nabokov fa parlare Humbert con una lingua raffinata e ricca, abile nel trasmettere le sensazioni di un personaggio profondamente disturbato emotivamente, che non ammette mai i propri peccati, ma che anzi tenta di giustificarli. Humbert è consapevole della sua ossessione, ma la sua auto assoluzione è inquietante quanto il suo comportamento. In questo senso, Lolita non affronta solo il tema della pedofilia, diventa infatti un’indagine su come l’autoassuluzione personale possa distorcere la realtà e piegare la verità a proprio piacimento.
Il fascino di Lolita sta anche nella sua capacità di creare una discussione su temi universali quali il desiderio, il potere e la moralità. Humbert presenta Lolita come una seduttrice, ma il lettore non può fare a meno di comprendere la verità nascosta dietro il suo linguaggio affascinante e manipolatorio. Questo dal mio punto di vista è uno degli aspetti più contorti della narrazione: Humbert nella sua deviazione fa ricadere la colpa delle proprie perversioni sulla vittima, convinto che egli sia giustificato ad avere comportamenti inappropriati con Lolita poichè è stata lei in primis a sedurlo. Il tema affrontato da Nabokov della vittima seduttrice ci porta a una riflessione più moderna: ancora oggi donne vittime di stupro e bambine vittime di pedofili vengono additate come le prime colpevoli, in quanto sono state (secondo i loro predatori) “loro a cercarsela”.

Sulla storia di Lolita sono stati prodotti due film, il primo del 1962 e il secondo del 1997. A mio parere quest’ultimo è il migliore tra i due; sia per la rappresentazione scenica sia per le interpretazioni degli attori. Inoltre in questa produzione il regista con la sua riadattazione trasmette, ancora più rispetto al libro, l’idea che sia stata Lolita dall’inizio alla fine spingere Humbert ad abbracciare le sue perversioni.

La lettura di Lolita è indubbiamente stata una tra l’esperienze letterarie più disturbanti che io abbia provato, ma allo stesso tempo la capacità di Nabokov di mantenere un delicato equilibrio tra la bellezza della lingua e la brutalità dei temi mi ha estremamente affascinato e a mio parere è proprio questa tensione tra forma e contenuto che rende l’opera un classico indiscutibile. Lolita mi ha personalmente portato a una riflessione più ampia sull’uso delle parole: queste possono essere utilizzate per manipolare la mente di qualcuno facilmente assoggettabile, come Lolita, ma può allo stesso tempo rivelare l’inquietante verità dietro l’illusione apparente, come comprendono i lettori più attenti.
Infine Lolita è una lettura difficile ma fondamentale per chiunque voglia comprendere i confini tra arte e moralità e il potere che la letteratura ha nel manipolare le emozioni e le percezioni dei lettori. Il romanzo può essere un testamento del potere dell’arte di trasmettere riflessioni anche sui temi più oscuri, ma allo stesso tempo ci pone quindi una domanda scomoda: fino a che punto un’opera d’arte giustifica il suo contenuto?
Flavia Delle Monache, 4DC